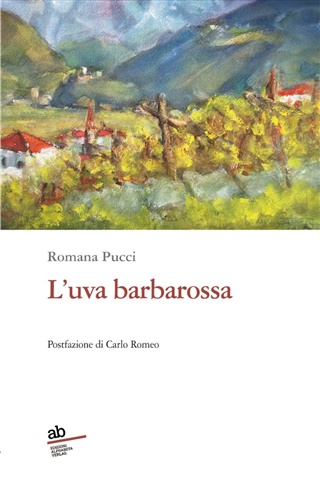Bolzano al tempo di guerra nelle memorie adolescenziali di Romana Pucci, poetessa e prosatrice “toscana” da non dimenticare.
La pubblicazione del romanzo di Romana Pucci “L’uva barbarossa” (Edizioni alphabeta Verlag 2021, Euro 14.00) prosegue la ricognizione della narrativa d’ambientazione (o ispirazione) altoatesina che la casa editrice di Merano sta meritoriamente compiendo guardando a titoli da tempo irriperibili nelle librerie; titoli che però vale la pena recuperare alla luce di due spunti non trascurabili: la qualità della scrittura e la cura della memoria territoriale redatta in lingua italiana. Così, dopo il bel libro di Gianni Bianco (“Una casa sull’argine”) apparso l’anno scorso, ecco la seconda uscita della collana “TravenReprint” con questo volume stampato in origine da Rusconi nel 1983.
Romana Argia Maria Pucci (nata a Borgo Buggiano, nel pistoiese, nel 1928, e morta a Milano nel 1990) è una “altoatesina” sui generis, vale a dire immigrata, come in gran parte lo sono tutti quelli che non possono fregiarsi del titolo di autoctoni. Le origini della famiglia sono infatti toscane, dato che non è di secondaria importanza per interpretare il ductus della sua poetica. Dopo aver trascorso parte dell’infanzia nella terra degli avi, la famiglia si sposta al nord, prima a Verona, quindi a Bolzano (nell’ottobre del 1940), seguendo i trasferimenti del padre ferroviere. Ed è proprio l’ambientazione bolzanina a caratterizzare il suo secondo romanzo (il primo – “La volanda” – uscì da Einaudi nel 1979 e venne molto lodato dalla critica nazionale). Aprendo il libro a pagina 62 (siamo all’incipit del capitolo intitolato “L’esilio”) incontriamo già alcune descrizioni che individuano la tonalità affettiva di una Entfremdung – nota costante e comune a tanti “spatriati” da queste parti –, declinata in modo lirico: «Una cerchia sconnotata, senza storia, né tradizioni, né linguaggio in comune e, in mezzo, rocca asburgica di cittadini asburgici ottativi italiani (per la terra, che è lo zoccolo della patria), machiavellati dall’indole e dai luoghi a sventare le trame di nord e sud, e pigliar da questo e quello, fingendosi pigliati». Il curatore del volume, Carlo Romeo, richiama gli elementi salienti della sua prosa d’arte, citando la «profondità del recupero memoriale e l’originalità della scrittura, la contaminazione tra registri letterari, colloquiali e dialettali, un repertorio lessicale così fuori dall’ordinario da affascinare persino un severo filologo come Roberto Ridolfi». Ma di cos’è fatto propriamente il libro, posto che il contenuto di un romanzo non possa certo risiedere “solo” nella lingua in cui è scritto?
Ancora Romeo: «Se nel primo romanzo i ricordi dell’infanzia toscana sembravano trasfigurarsi in allegorie senza tempo, come le favole, qui le esperienze irrompono, dissonanti e persino brutali, attraverso la percezione della più irrequieta delle età umane, l’adolescenza. La scrittrice cerca di restituirne gli echi con la massima fedeltà, col massimo grado di regressione possibile, producendo a volte un effetto quasi diaristico. Il vissuto coincide con un periodo quanto mai denso di avvenimenti di forte polarizzazione e impatto emotivo: la guerra, la caduta del fascismo, l’occupazione nazista, i bombardamenti. Agli occhi di un’adolescente il mondo impazzito degli adulti non può offrire certezze, con i miti che crollano di colpo come le case buttate giù dalle bombe, e nessuna frase imparata a scuola sembra reggere alle prove della vita e della storia». Si tratta, in effetti, quasi di emozioni stenografate, di un crepitante svolgimento interiore che – mentre è proteso a ricostruire il volgere di un’epoca – si avvale costantemente di un punto di appoggio familiare, costituito dalle frasi scaturite dal dialogo con il padre della protagonista: un “fascista sentimentale”, più che ideologico, al quale il libro è dedicato e del quale le pagine delineano un commosso ritratto della sua personale decadenza, nel disfacimento del Regime di Mussolini.
Un episodio, in particolare, addensa il fuoco dell’ispirazione. Siamo nel 1945, al termine dell’occupazione tedesca dell’Alto Adige-Südtirol, e gli ultimi bagliori degli scontri fanno versare ancora molto sangue. «È il tre maggio, a guerra finita escono al sole i partigiani. Li conosco, sono ragazzi del contado, a casa propria fino a stamattina. […] Per qualche ora è una guerra assurda, questo infine è un esercito, gli altri, ragazzi e male armati. Sul finire odo detonazioni dal cortile e strazio di voci sotto a noi. Non ricordo l’età, forse quattordici, unico maschio. Il babbo accorre ma, sulla soglia di cucina, batte l’aria, poi cade. Lo sento dire: “Meglio me, potevano prendere i figlioli”. E si smarrisce. Ha l’avanbraccio spappolato da una palla esplosiva, si vede l’osso a schegge». La scena è drammatica. Piovono colpi, tutti fuggono, ma il padre ferito è percosso in modo ancora più amaro da un epiteto di chi passa e di lui non si cura: “Fascista!”. Qui non è tanto importante stabilire la stretta veridicità dell’episodio, quanto piuttosto afferrare la percezione morale che ne guida la ricostruzione. Proprio nel momento di massima difficoltà e di crisi, quando cioè la sicurezza dei punti di vista più consolidati vacilla, o addirittura si ribalta, affiora la richiesta che gli uomini siano riconosciuti come tali, senza ulteriori specificazioni. Non essendo avvenuto prima, traiamo però noi la cruda conseguenza, come sarebbe stato possibile accadesse proprio nel momento decisivo? Forse, ostinato benché sconfitto, resta appena quel desiderio di umanità ridotta all’essenza, ombreggiata da un frutto modesto e dalle parole della poesia “Testamento” di Olindo Guerrini: «Quando morrò, lungo la terra smossa / non piantate il cipresso o la mortella / io la mia tomba non la voglio bella / Piantateci una vite! / E così, benché morto, il mio tributo / ai vivi pagherò, rendendo al mondo / qualche goccia del vin che gli ho bevuto».
ff – 13 maggio 2021