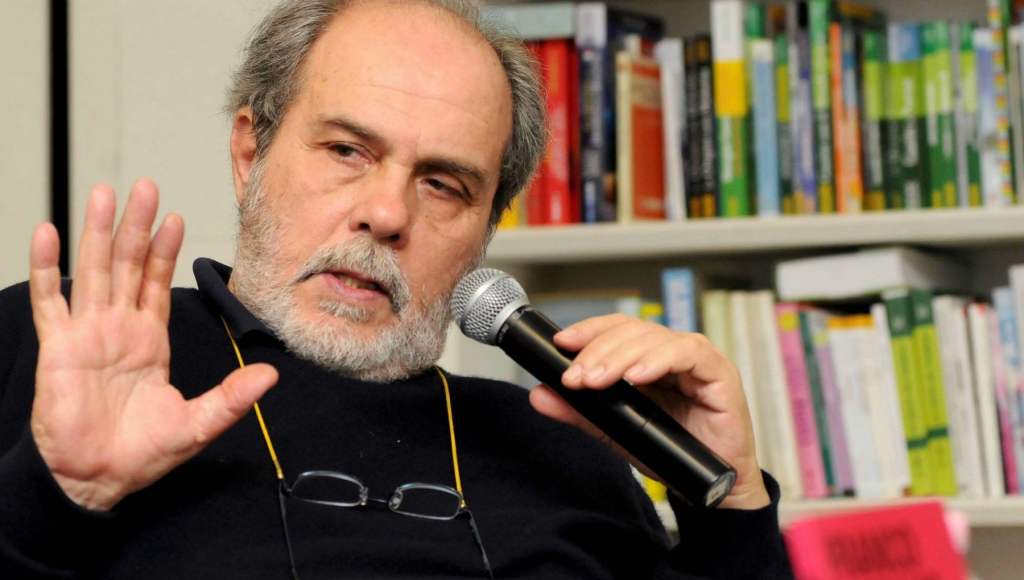Questa breve nota (preludio dell’intervista che la conclude) è intesa come raccolta di un materiale utile a impostare il senso di una domanda: alla psichiatria serve la narrazione? La parola “narrazione” include anche la sua specificazione artistica, cioè la “narrativa” propriamente detta. Quindi anche racconti o romanzi che parlino di “follia” e di rapporti con la “follia”. Lo spunto mi è offerto da un libro molto bello (La sindrome di Ræbenson, Atlantide 2023) scritto da uno psichiatra assai dotato dal punto di vista letterario: Giuseppe Quaranta. Prima di passare all’intervista, ecco alcune dichiarazioni dell’autore trovate in rete:
“Ho riflettuto su cosa significhi avere una malattia psichiatrica, sulla difficoltà che c’è spesso di comunicazione tra chi ha un disturbo psichico e i suoi conoscenti, sul fatto che molto spesso le diagnosi siano insufficienti per esprimere i vissuti di ciascuno, e che la sindrome di Ræbenson, nella sua irrealtà, non sia meno reale di tante diagnosi codificate nei manuali diagnostici e che sono però lontane dal buio di solitudine e disperazione in cui sono molti”.
Forse la letteratura è un modo per accendere una luce in quel buio.
Intervista a Giuseppe Quaranta
Qual è stato il percorso che l’ha portata ad affrontare letterariamente un tema di natura psichiatrica?
Si consiglia sempre agli scrittori esordienti di occuparsi del proprio piccolo pezzo di terra, e io mi sono attenuto il più possibile a questo consiglio: ho cercato una storia tra le cose che conoscevo meglio, quelle inerenti la mia professione. Sicuramente, la rara libertà di parola concessa al paziente con disagio psichico ha fornito a moltissimi scrittori la cornice perfetta per una confessione di fantasia. Penso ad esempio a “La coscienza di Zeno”, ma anche a “Lamento di Portnoy”, a “Il giovane Holden” di Salinger. Quello che intravedevo in quei libri era una completa assenza di dialogo tra paziente e terapeuta. Nessun ponte. La figura dello psichiatra in questi romanzi rimaneva perlopiù fuori dalla storia. Lo psichiatra di Roth, ad esempio, non parla mai. Sono oggetti, non interlocutori. Lo strizzacervelli nei romanzi, generalmente, è quasi sprovvisto di vita interiore. L’idea dell’analista o psichiatra come figura neutrale mi ha sempre colpito per la sua fallacia, così come chiaramente qualsiasi nozione di oggettività in campo scientifico. Il narratore-psichiatra che segue le vicende di Deltito nel mio romanzo, La sindrome di Ræbenson, non rimane sullo sfondo, non mantiene le distanze come ci si aspetterebbe, ma si cala nella storia, partecipa ai vissuti, si lascia assorbire.
Quali nessi vede nel plesso letteratura salute/disagio mentale?
Penso che il disagio mentale amplifichi le possibilità della letteratura, così come ogni forma di sguardo differente e non omologato sulla realtà. Lo scrittore, da questo punto di vista, è come un paziente; ha la stessa difficoltà. Come succede nell’anamorfosi, una tecnica pittorica che non ti consente di vedere l’oggetto all’interno di un quadro fino a che non ti sposti e non lo osservi da un’angolatura differente, anche lo scrittore, come i pazienti, ha bisogno di spostarsi per vedere come risolvere o mettere a fuoco il suo problema. Il luogo della trattativa, diceva Manganelli, si trova sempre altrove, ed è spesso un luogo periclitante, faticoso, ma è l’unico possibile. La terapia è solo di tipo psicoeducativo: la letteratura ha a che fare con un esercizio costante delle proprie facoltà intellettive, con una espansione della propria coscienza. Questo non può che essere una forza.
Che autori o libri consiglierebbe per mettere ulteriormente a fuoco il tema?
Gli autori o i libri che hanno trattato il disagio psichico sono tanti. In Italia, abbiamo Tobino, Berto, Morselli e tanti altri… Per quanto riguarda i contemporanei, penso a “L’uomo che trema” di Pomella, a “Svegliami a mezzanotte” di Fuani Marino… Consiglio, inoltre, un libro meraviglioso di Carmen Maria Machado, “Nella casa dei sogni”, la storia di una relazione tossica, borderline. Molto belli anche i libri di Siri Hustvedt.